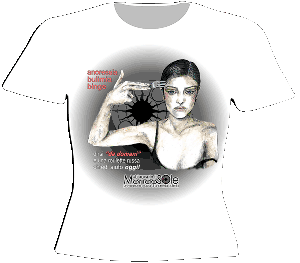ORA NE SONO CERTA: SI PUO’ GUARIRE DALL'ANORESSIA e dalla BULIMIA
I PROBLEMI CON IL CIBO, PER CHIARA, SONO INIZIATI A 6ANNI.
MANGIARE PER LEI ERA COME FICCARSI UN
COLTELLO NELLA PANCIA.
GUARITA, HA VOLUTO CONDIVIDERE IL SUO
CALVARIO. E HA FONDATO UN CENTRO DI CURA PER I DISTURBI
ALIMENTARI
Cibo masticato,
sputato, desiderato, rifiutato, odiato. Intorno a tutto
questo ha ruotato gran parte della mia vita. Non c’era
altro. E quando diventò un fardello troppo grosso da
sopportare tentai il suicidio.
Avevo 18 anni all’anagrafe, ma cento nel
cuore e nella testa. Aprii il mobiletto dei farmaci, ingoiai
tutto quello che trovai all’interno, poi, prima di perdere i
sensi affidai la mia sopravvivenza al destino. Chiamai il
mio fidanzato: “Sono Chiara, sto morendo”, dissi. Poi misi
giù. “Se arriverà in tempo vorrà dire che devo vivere”
pensai. Lui mi portò in ospedale e mi salvarono. Dopo
quell’episodio mi feci
tatuare un sole sul
polso e modificai il mio nome in Chiara Sole, vestendolo
di speranza.
I miei problemi con
il cibo sono cominciati a 6 anni. Il medico di famiglia
aveva detto ai miei genitori che ero un po’ in sovrappeso,
così loro presero a controllare ogni cosa che mangiavo. Io
mi abbuffavo di nascosto, mandavo giù tutto quello che
trovavo e lo facevo con gioia gustandomi ogni boccone. Una
volta mi sorpresero a mangiare un uovo di cioccolata intero,
e me le diedero di "santa ragione". Pensavano che avrei
imparato la lezione, ma non fu così. In una famiglia in cui
ogni argomento ruotava intorno al cibo e l’ossessione per la
forma fisica assumeva sembianze quasi palpabili, non poteva
che andare a finire male. I problemi veri, quelli più
evidenti, cominciarono a 11 anni, con l’arrivo delle prime
mestruazioni. Era colpa mia se il mio corpo non era più
quello di una bambina, se diventavo più rotonda, se i miei
fianchi cominciavano ad ammorbidirsi, ad allargarsi?
Pensavo alla disapprovazione dei miei
genitori, e
provavo impotenza
e disperazione.
L’unica cosa che potevo dare era dedicarmi ossessivamente
all’esercizio fisico e smettere di mangiare. Così cominciai
una dieta rigidissima, dividendo i cibi permessi da quelli
tabù. Passavo la giornata a correre, spesso saltavo i pasti
e ogni boccone in più rispetto a quanto pianificato mi
procurava un senso di colpa insopportabile. Dovevo dimagrire
a tutti i costi, la mia intera vita dipendeva solo dal
responso quotidiano della bilancia. Man mano che perdevo
peso, mi sentivo sempre più sicura di me stessa, convinta di
avere il totale controllo sul mio corpo. Non mi rendevo
conto che era la malattia a controllare me, i miei gesti le
mie giornate. Le persone normali vogliono dimagrire, io
volevo annullarmi,
scomparire. Il cibo era la vita, e io non ne volevo più
sapere di vivere. Mangiavo solo cibi senza sapore, sempre
gli stessi. Temevo di non riuscire a gestire un sapore
diverso, un’emozione nuova. Avevo paura che anche un
piccolissimo cambiamento nello schema del quotidiano avrebbe
potuto uccidermi. Cominciai ad avere anche crisi di panico.
All’improvviso mi sembrava di soffocare.
A 12 anni arrivò il primo ricovero d’urgenza, per una
gastrite acuta legata al mio folle regime alimentare. Io ero
diventata solo una spettatrice: l’anoressia stava
distruggendo il mio corpo e io mi ci ero accoccolata dentro.
Un giorno, dopo l’allenamento quotidiano
di tre ore e la sauna, presi in mano il pacco di biscotti
alla soia che avevo in borsa. Di solito me ne concedevo tre,
ma quel giorno fui presa da un impeto incontrollabile e
divorai tutto il
pacchetto. Un biscotto dietro l’altro, con le lacrime
agli occhi.
Iniziò così un’altra fase, quella delle
abbuffate compulsive. Passai sa
Anestetizzata dal
dolore
Non ero più capace
di parlare con la gente, ne avevo paura. Immaginavo che
tutti ridessero di me. Morivo, un giorno dopo l’altro.
Eravamo soli, io e la mia rabbia, e non c’era posto per
nessuno. Quando avevo bisogno del cibo, me lo procuravo,
anche dalla pattumiera, se necessario, anche surgelato,
crudo. Se non trovavo niente da mangiare avevo terribili
crisi isteriche, mi strappavo la pelle dalle mani e dai
piedi. Il dolore fisico mi serviva per non sentire il vuoto
che mi portavo dentro. Più dolore c’era fuori, meno ne
sentivo nel cuore. Una volta mi trovavo a Perugia per una
terapia. Il mio appartamento era sopra a un fast food e io
non riuscivo a starne lontana. Mi ricordo lo sporco della
stanza, il cibo sparso dappertutto, il mio corpo steso sul
pavimento del bagno. Mi ricordo il sapore del sangue in
bocca, dopo il vomito, la solitudine e il mio desiderio di
avere un infarto, un ictus, o qualcosa che mi aiutasse ad
uscire da quell’inferno. Tornai a casa e presi 30 chili in
un mese, a causa di un blocco metabolico. La mia vita era
distrutta e
anche quella della mia famiglia. Loro non sapevano come
aiutarmi e io non volevo essere aiutata. Ogni giorno il muro
che avevo davanti diventava sempre più alto. Fui ricoverata
decine di volte, provai terapie familiari e sedute di
psicoanalisi, cercai aiuto anche in Florida, ma non servì a
niente. Le poche storie d’amore che ebbi in quegli anni
erano anch’esse, a modo loro, delle dipendenze distruttive.
Mi illudevo che la persona che avevo accanto potesse darmi
l’antidoto alla morte. Ma non funzionava mai. Rimasi in
fondo al burrone ancora per quattro anni, poi attraverso una
terapia ininterrotta di tre anni, cominciai a guarire. Mi
risollevai perché ero stremata. Non riuscivo né a vivere né
a morire. Ma non riuscivo neanche più a sopportare il limbo,
perenne, in cui fluttuavo.
Sempre più a fondo. Mi resi conto che
gran parte dei miei disturbi nascevano da dinamiche
familiari complesse, problemi che i miei genitori si
portavano dietro da prima ancora di
diventare genitori,
e che erano piombati su di me da bambina, schiacciandomi
completamente. Firmai una tregua con il cibo. Imparai a
familiarizzare con i diversi sapori, a capire che il cibo è
un gesto di amore, che va assaporato con calma, come la
vita. Dopo la cura dallo psicologo, scelsi un ricovero in
una comunità terapeutica, perché avevo bisogno di re
imparare la quotidianità, di capire cosa significasse vivere
ogni giorno con altre persone, interagire con loro e
imparare a mettermi in gioco.
Appena uscita, scrissi un libro e
raccontai in un sito la mia esperienza. Volevo parlare del
mio dolore, adesso che me l’ero lasciato alle spalle,
aiutare chi stava soffrendo e non riusciva a risalire,
attraverso la testimonianza della mia malattia. Mi risposero
centinaia di persone e nel 2004 scelsi di creare “MondoSole”,
un centro per la cura dei
disturbi alimentari.
Quand’ero anch’io nel baratro, desideravo
più di ogni altra cosa avere una persona che mi ascoltasse e
che guardandomi negli occhi mi dicesse: “Ti capisco, perché
io quel mostro l’ho portato dentro e ora l’ho scacciato per
sempre”. Io so riconoscere l’inferno negli occhi di chi
viene da me, e posso dirgli con certezza: “Se lo vuoi
veramente, puoi ricominciare a vivere”.